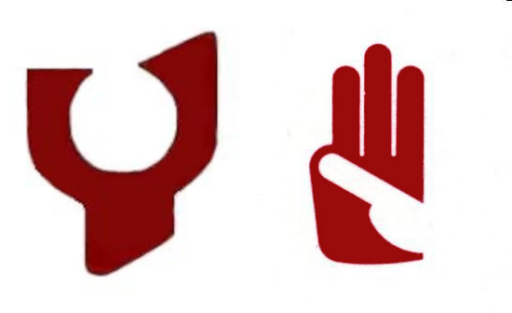Indice
BADEN E LO SCAUTISMO CATTOLICO
Nello scoutismo cattolico è sempre stata discussa l’identità dell’assistente ecclesiastico e specialmente ai tempi di don Ghetti, quando c’erano sacerdoti a sufficienza perchè in certe realtà cittadine o grosse parrocchie si potesse destinare un sacerdote all’esclusivo servizio dei gruppi scout. Doveva essere un prete-scout o uno scout -prete?
La “colpa” della questione era quasi esclusivamente sua perché, animando i campi di formazione per assistenti scout, si metteva in gioco totalmente, con la grande capacità di animazione e coinvolgimento di cui era naturalmente dotato, tanto da diventare un modello.
Per lui la questione non esisteva: vita sacerdotale e scoutismo si erano unificate in una personalità onesta e forte, impulsiva e timida, contraria ai compromessi, rude e capace di tenerezza e finanche di sentimentalismi, autenticamente innamorata di Dio e dell’uomo.
Divenne scout a 14 anni, nel gruppo Milano XI; lo scoutismo fu per lui lo stile per vivere tutta la vita con spirito di avventura (spesso spiegava: “ad ventura”, sempre in cammino alla ricerca di cose nuove) e di servizio, intensamente e comunitariamente.
Entrò in seminario dopo la laurea in filosofia del 1935, celebrò la prima messa nel 1939, in pieno periodo di clandestinità per lo scoutismo, le cui formazioni si erano autonomamente sciolte prevenendo i decreti autoritari del regime fascista.
Per lui lo scoutismo era davvero quella “route de liberté” di cui parlava il père Forestier degli Scouts de France e la visse fino in fondo specialmente nell’esperienza delle “Aquile Randagie”. Si chiamò così quel gruppo di scout, fondato e guidato da Giulio Uccellìini che in clandestinità sfidò autorità, polizia e divieti per 17 anni dal 1929 al 1945, vestendo provocatoriamente l ‘ uniforme anche in luoghi non “protetti” come la tenuta della famiglia Osio a Colico o la mitica Val Codera (si veda il box).
In maniera tipicamente scout il nome di un animale e un attributo significavano la condizione di chi non voleva rinunciare alla propria libertà essendo dignitosamente “randagi”, senza casa.Dopo il 25 aprile don Ghetti si dedicò alla ricostruzione dell’ASCI (l’associazione di scout cattolici nata nel 1912) riproponendo l’autenticità del metodo educativo ideato da Baden Powell; in particolare si dedicò alla strutturazione metodologica della “branca rover” (per ragazzi dai 16/17 anni in poi) che considerava la più delicata perchè rivolta ai ragazzi nel periodo delle scelte defintiive per la vita; con intuito pedagogico, fiducia nelle possibilità dei giovani e fantasia, inventò e diresse grandi “imprese” e leggendarie operazioni al servizio di emergenze e calamità, nel Polesine per la grande alluvione del’59, nel Vajont, in Friuli per il terremoto, in Ungheria o a fianco di fratel Ettore fra i barboni della Centrale.
Lo scoutismo italiano gli è debitore di quarant’anni di coerente e a volte testarda testimonianza, in particolare quando negli anni della “contestazione” ,di cui non è stato esente il movimento, c’erano forti tentazioni al compromesso e alla mediazione.
Negli ultimi anni della sua vita, in particolare dopo il 1974 quando dall’unione delle due associazioni maschile (ASCI) e femminile (AGI), nacque l’AGESCI, temendo uno svuotamento di valori e prevedendo un eccessivo ammorbidimento della proposta educativa scout, si fece molto critic; e pagò la coerenza e il coraggio delle sue convinzioni con l’isolamento e la solitudine.
Ha scritto Giancarlo Lombardi poco dopo i commossi funerali del 14 agosto 1980 nella sua chiesa del Suffragio: “Devo dargli testimonianza, in una società così ricca di mezze figure, di uomini di poco carattere e poca passione, di essersi sempre battuto per ciò in cui credeva senza risparmiarsi nel fisico e nello spirito, senza mai calcolare se gli sarebbero derivati riconoscimenti, soddisfazioni, incomprensioni o fatica”.
Nel 1939 Gaetano Fracassi, uno scout clandestino delle “Aquile Randagie” fece scoprire ai suoi compagni la Val Codera, una aspra valle laterale della val Chiavenna che inizia dalla sponda del laghetto di Mezzola, a tutt’oggi abitata pur non essendo dotata di strada; una valle ideale per chi cerca natura intatta e gente dalla umanità autentica; per chi vuol vivere la libertà completa dei figli di Dio.
Dai campi delle Aquile Randagie del periodo clandestino, con don Ghetti, e poi dai campi scuola (per assistenti ecclesiastici e per capi laici) alle routes dei giovani rover, è nata e si è consolidata una forte amicizia con gli scout.
In questa semplice testimonianza di una ragazza nata e cresciuta in valle c’è il vivissimo ricordo della presenza di don Andrea Ghetti che anche qui ha lasciato una traccia incancellabile. Quando Baden (nome in codice di don Ghetti, usato nella clandestinità e rimasto poi come un “nome di battaglia”) saliva a Codera con i suoi scout, era sempre una festa.
Gli abitanti del paese si davano da fare per organizzare l’accoglienza. Si aprivano le case, si cucinavano i dolci della festa e si ornava la chiesa con i fiori più belli. Qualcuno si preparava per la confessione; si celebrava la S.Messa delle grandi occasioni. Sembrava di ricevere la visita del Papa. Lo chiamano Baden, ma per noi era il “monsignùr”.
Ricordo quando, insieme agli altri bambini, andavamo ad aspettarlo alla cappellina del Mut, un centinaio di metri sopra l’uscita della seconda galleria, poco prima del cimitero. Il suo arrivo era anticipato dall’eco della sua voce potente, che spronava quelli più indietro. Poi arrivava, e appena fatta la curva sotto la cappellina, guardava in alto, per vedere se c’eravamo. Il suo sguardo verso l’alto… ricordo ora quel suo gesto, che diceva bene quanto anche lui fosse felice di vederci. Si aspettava di trovarci lì, e noi c’eravamo.
Si celebrava la Messa e poi, dopo cena, era per noi bambini il momento più atteso: il falò in piazza, con danze, scenette, animazioni. Con i grandi ci fermavano tardi a cantare i canti scout e i canti della valle.
Il giorno dopo salivano alla Capanna Brasca. Al ritorno, Baden di nuovo si fermava casa per casa e raccoglieva le esigenze della gente. Ascoltava tutti con attenzione, e trovava parole di conforto e incoraggiamento. E che dispiacere, quando ci si salutava…
Ricordo di quell’uomo i modi bruschi e il cuore così generoso. Sempre pronto a fare il possibile per dare una mano. Voleva bene a tutti e tutti gli volevano bene. Quando c’era lui, il paese era in festa.
Ricordo la sua presenza imponente, la sua voce imperiosa, i suoi silenzi interrotti da esclamazioni improvvise. Ero una bambina e provavo nei suoi confronti un misto di soggezione, riverenza e affetto figliale. Ricordo quei suoi rimproveri, tuonati con una severità teatrale, che lasciava bene intendere tutto l’affetto che l’accompagnava.
Baden ha fatto molto anche per me. Se a quell’età ho potuto superare momenti molto difficili, lo devo anche a lui e ancora oggi conservo nei suoi confronti un’infinita riconoscenza.
Ancora oggi, a Codera, nelle case di quelli che l’hanno conosciuto c’è un angolino riservato alla foto di Baden. Ancora oggi, a 25 anni dalla sua morte, quando ogni tanto racconto di lui ai giovani scout, mi prende un po’ di magone e mi accorgo di quanto mi manca.
E’ venuto a mancare troppo presto e spero che da “lassù” continui a volerci bene……….
Grazie “Monsignùr”
Ileana O.
DON ANDREA E IL SEGNO
Dopo la Grande Missione di Milano del 1960 (??) il cardinale Montini pensò di prolungarne i risultati attraverso un periodico mensile da diffondere nelle parrocchie della Diocesi e che facesse da supporto ai numerosi bollettini parrocchiali; l’idea per quei tempi era coraggiosa più che innovativa. Il giornale avrebbe rappresentato e voleva essere la voce del Vescovo al suo popolo, il commentario al magistero della Chiesa, una palestra di idee e dibattiti e, perché no, anche avrebbe dovuto essere una lettura divertente ed immediata.
Ebbe subito un buon successo anche perchè a dirigerlo chiamò don Andrea, il quale, essendo convinto della attualità del progetto, vi impegnò creatività, sensibilità pastorale e quella competenza psicologica, grazie alla quale riuscì sempre a proporre in modo comprensibile argomenti complessi.
Costituì una piccola redazione nella quale aveva coinvolto, nell’avventura del Segno grazie alle amicizie e al prestigio che godeva, giornalisti e scrittori di grande professionalità quali Morati, De Fabiani, Negri, Caporali, …. che con spirito di servizio e umiltà davano forma alle sue idee. La redazione aveva sede nell’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali, allora diretto da mons. Ernesto Basadonna e poi da Mons. Majo.
Era rigoroso e severo come deve essere ogni buon direttore di giornale, pronto all’arrabbiatura per le cose …. non meno che alla battuta fulminante dettata da uno umorismo spontaneo o da bonaria ironia; tra le persone “colpite” dalle sue battutine non mancava un collaboratore fisso, titolare della rubrica “Le opere e i Giorni” che, a differenza della maggior parte dei redattori, puntualissimamente, e diligentemente, consegnava le sue consuete 36-40 righe: era un “professorino” della Facoltà Teologica di nome Dionigi Tettamanzi…
Il suo modo di condurre la redazione non era molto convenzionale, voleva infatti che partecipassero non solo i giornalisti, ma anche lo stampatore, il grafico, il fotografo, i collaboratori dell’ufficio di Curia, precorrendo le attuali tendenze giornalistiche che fanno del giornale un atto di produzione totale. Grazie alla sua carica umana, le riunioni erano incontri tra amici felici di lavorare insieme e ancor più nella coscienza di svolgere un servizio alla chiesa milanese. E non perdeva occasioni per lanciare delle attività da vivere, da “vecchio” scout, con sano spirito di avventura.
Come fu nel 1974, quando pensò di presentare ai lettori del “Segno” in modo originale l’Anno Santo. Inventò una piccola guida di Roma più religiosa che turistica e per produrla formò una squadra con il grafico e lo stampatore, che erano anche buoni fotografi, e il responsabile della Pastorale del Turismo; stesa la traccia dell’opera, andò a Roma in auto e in tre giorni di intenso lavoro fotografarono monumenti, stabilirono contatti, sperimentarono i percorsi e infine la piccola guida, stampata a colori, faceva la sua apparizione come allegato del Segno di dicembre 1974.
Il mensile fu gradito da parroci e parrocchie; don Ghetti lo voleva dignitoso e sobrio nella forma, graficamente curato; non voleva nè poteva confrontarsi con i primi rotocalchi patinati quali Epoca, l’Europeo; inizialmente era stampato in bianco e nero, poi si potè usare un secondo colore in copertina e solo negli anni ’70 apparve la quadricromia in copertina e in qualche inserto speciale; ebbe molto successo la formula di inserire nel corpo della rivista uno o due “quartini” con le cronache ed avvisi delle parrocchie , che provocavano un lavoro infame allo stampatore, quel Boniardi che aveva una delle più vecchie linotipie di Milano ma che fu tra i primi a sostituire le vecchie macchine con la composizione elettronica.
Quando morì, si stava preparando il numero del Segno che avrebbe festeggiato il 20*anno dalla fondazione; la tiratura era ancora altissima, superiore alle 150.000 copie mensili; il Cardinale Colombo aveva già consegnato in redazione il suo messaggio augurale; il capo redattore De Fabiani lesse il suo “pezzo”
VAJONT
UNGHERIA
CENNI SULLA VITA
Nasce a Milano, in una casa di periferia di via Milazzo a P.ta Garibaldi, Antonio Andrea Ghetti, terzo di quattro figli.
1927 in vacanza con i genitori a Vittoria Apuana, presso Forte dei Marmi, incontra casualmente un gruppo di Esploratori pistoiesi e ne rimane incantato. Rientrato a Milano, ricerca caparbiamente un Gruppo Scout ed alla fine incontra il MI XI Cardinal Ferrari che lo accetta, insieme al fratello minore Vittorio, dopo aver superato non poche difficoltà.
1928, aprile, Andrea è ammesso a pronunciare la Promessa Scout in pieno periodo di scioglimento delle Associazioni degli Esploratori.
6 maggio 1928, domenica, per ordine del fascista Mussolini lo scoutismo è cancellato ed il suo MI XI si ritrova nella chiesetta dell’Opera Cardinal Ferrari per sciogliersi secondo i dettami del Papa.
20 maggio un minuscolo gruppo di Scout effettua, imperterrito, l’uscita domenicale e si industria per cercare forme diverse per poter continuare a svolgere l’attività Scout. Andrea aderisce alle numerose iniziative.
1929 in autunno, dopo molti tentativi falliti, nascono le Aquile Randagie.
1930 per opposizione della madre, riguardo ad una incerta vocazione sacerdotale, Andrea decide di iscriversi a medicina.
1931 uscendo da una lezione universitaria, reagisce violentemente alle provocazioni di un fascista. Braccato dagli squadristi, si rifugia a Schilpario.
1932 comincia a delinearsi energicamente la sua vocazione religiosa per questo, durante la fine dell’inverno, cambia facoltà passando a filosofia e, su intuizione di p. Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica, segue un suo corso sperimentale di psicologia.
11 maggio 1935 muore la mamma. Il 30 ottobre discute la tesi di indirizzo psicologico, rifiutandosi di indossare la camicia nera e, senza indugio, l’8 novembre entra nel Seminario Lombardo di Roma. Il 14 novembre è laureato a pieni voti dottore in filosofia.
1937 partecipa clandestinamente al Jamboree di Voghelenzang in Olanda ed il 9 agosto la delegazione delle Aquile Randagie è ricevuta ufficialmente da Baden Powell in persona, che rimane affascinato da questo piccolo gruppo di irriducibili.
26 marzo 1939 celebra la prima Messa nella sua Parrocchia di S. Maria Incoronata, a Milano, e diventa Assistente delle Aquile Randagie. Per ordine del card. Schuster non completa gli studi di teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, conseguendo solo la licenza del IV anno. Tornato a Milano, in settembre, sale per la prima volta in Val Codera. Il suo ministero inizia al Collegio A. Volta di Lecco per insegnare filosofia ai Prefetti e ai Chierici a cui aggiunge l’insegnamento di religione all’Istituto Tecnico G. Parini. Organizza la scuola di religione per gli universitari lecchesi, fondando il gruppo FUCI.
1940 rientrato a Milano è inviato come Vicario a Creva di Luino per la sua prima esperienza pastorale. Da ottobre insegna filosofia e storia presso il liceo del collegio Arcivescovile S. Carlo di Milano. Parallelamente diventa Assistente della FUCI insieme a don Luigi Polvara, don Carlo Gnocchi e p. Genesio da Milano.
12 settembre 1943, dopo il casuale espatrio clandestino di un giovane scozzese, fonda OSCAR (Opera Scoutistica Cattolica Aiuto Ricercati) con la collaborazione di don Giuseppe Enrico Bigatti, don Aurelio Giussani, don Natale Motta e le Aquile Randagie. Saranno anni molto intensi, col rischio continuo di venire ucciso o, nella migliore delle ipotesi, finire in un campo di concentramento. Notevole e poco conosciuto sarà il bilancio in vite umane salvate, non senza lutti fra i membri di OSCAR.
25 marzo 1944 è nominato nel primo Commissariato Centrale ASCI di Roma, che è provvisorio e clandestino, ma a causa della guerra non potrà mai parteciparvi.
1945 dopo la Liberazione, inizia la ricostruzione dello scautismo, con una parentesi in giugno e luglio per partecipare alla Missione Ambrosiana per il rimpatrio dei sacerdoti italiani scampati all’eccidio nei campi di concentramento, utilizzando un treno preso, nientemeno, in prestito dagli Ungheresi. Al suo ritorno è eletto Assistente Ecclesiastico Regionale ASCI della Lombardia.
1946 in accordo col card. Schuster, lascia la FUCI e l’insegnamento al S. Carlo per dedicarsi completamente al rilancio dell’ASCI ed inizia l’insegnamento di religione al liceo Parini.
1948, in gennaio, esce il primo numero della rivista RS Servire da lui fortemente voluta per supportare il nascente roverismo, anticipando la pubblicazione di Strade al Sole da parte del Commissariato Centrale ASCI.
17 luglio-28 agosto 1949 partecipa al Rover Moot di Skjak in Norvegia, ideando La Freccia Rossa della Bontà per raccogliere fondi, nelle varie nazioni attraversate, a favore dei mutilatini del suo amico don Gnocchi.
18 novembre 1951 le eccezionali piogge causano l’alluvione del Polesine e Baden progetta il primo intervento Rover a favore delle popolazioni colpite.
11 novembre 1956 riceve le insegne di Monsignore Canonico Onorario della Perinsigne Basilica di S. Ambrogio.
21 novembre, a capo di una delegazione della Diocesi, comprendente alcuni Rover, parte per il confine austo-ungherese per aiutare i profughi della martoriata popolazione ungherese invasa dai carrai armati russi.
4 ottobre 1959 diventa Parroco di Santa Maria del Suffragio di Milano che, con le oltre 40.000 anime, risulta essere tra le più popolose della più grande Diocesi del mondo.
1960, in gennaio, dopo 24 anni, lascia la carica di Assistente Ecclesiastico Regionale dell’ASCI lombarda continuando ad essere l’Assistente Ecclesiastico del Gruppo Scout MI I Gilwell e del Clan La Rocchetta. In aprile firma il primo numero de Il Segno, bollettino della Diocesi di Milano, fortemente voluto dal Card. Montini per concentrare i singoli fogli parrocchiali e far giungere la parola dell’Arcivescovo a tutti i fedeli. Manterrà, fino alla morte, l’incarico di Direttore Responsabile di questo periodico mensile religioso che raggiungerà la tiratura massima di ben 220.000 copie.
4 settembre 1963 è eletto Antistem urbanu seu prælatum domesticum da Paolo VI. Il 10 ottobre parte per coordinare i soccorsi della Diocesi Ambrosiana nella sciagura del Vajont indirizzando i militi della Croce Bianca ed i Rover de La Rocchetta all’allestimento del cimitero di Fortogna.
Insoluta è la domanda come riuscisse a ricoprire adeguatamente i suoi molteplici incarichi: Parroco; opinionista di varie riviste e quotidiani; Assistente Ecclesiastico della Polizia Stradale di Milano, della Croce Bianca milanese, del Centro Studi ed Esperienze Scout Baden Powell; Consigliere Amministrativo Diocesano del quotidiano L’Italia poi Avvenire; Incaricato Diocesano per la Pastorale del Turismo; insegnate di religione presso l’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice; rappresentante dei Parroci di Milano; Incaricato per le celebrazioni della Diocesi; fondatore dell’inserto Milano7; Delegato Diocesano nella Peregrinatio ad Petri Sedem; Segretario della Commissione Diocesana dell’Anno Santo; sostenitore di Fratel Ettore Boschin nell’aiuto ai “Signori Barboni” di Milano; Assistente Ecclesiastico del Riparto Scout MI I Nairobi, Clan e Comunità Capi del MI I Sud, Fuoco MI XXIV, Foulard Bianchi lombardi; ecc.
5 agosto 1980
Muore a Tours (Francia) in seguito ad un inspiegabile incidente stradale durante lo svolgimento del XXXIII Campo di Clan del MI I La Rocchetta Sud.
7 dicembre 1980 il Sindaco Tognoli consegna ai fratelli Ghetti l’Ambrogino d’oro; la più alta riconoscenza rilasciata dal Comune di Milano.
Dopo la riesumazione, le spoglie di Monsignor Andrea Ghetti-Baden riposano a Milano, nella Cappellina del Comitato Regionale Lombardo dell’AGESCI di via Burigozzo 11.